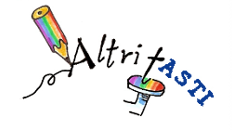Mio nonno era morto da vent’anni. Tre mesi dopo averne compiuti ottantadue. Tre mesi prima che io ne compissi tredici.
Mio nonno era morto da vent’anni. Tre mesi dopo averne compiuti ottantadue. Tre mesi prima che io ne compissi tredici.Mi ricordo che pioveva denso, quasi a nevicare. Mi viene in mente mio nonno, mentre mia madre mi chiede di metterle in moto il tosaerba.
Lei già ci aveva provato, senza successo.
Poi mio padre, senza voglia.
Il motore è ingolfato.
Credo di averci messo almeno mezz’ora prima che i quattro cavalli del motore sprigionassero la loro potenza ...
L’abbiamo usata non più di venti minuti quella potenza. Avanti e indietro.
Brandelli vegetali sparsi nel cortile.
Odore di bruciato, cotto.
Liquido vitale sprigionato da cellule violate.
Ricordo che mio nonno mi faceva osservare la punta interna della lama nel punto più largo, quello vicino al manico, che se dovessi disegnarlo sarebbe il lato più corto di un triangolo rettangolo, ma con gli altri lati curvi e poi mi raccomandava di fissare quel punto a terra.
Mi diceva, mio nonno, di guardare bene dove sarebbe passata la lama, la punta della lama rispetto a quel punto misterioso che avevo immaginato fisso lì tra l’erba.
Allora, solo allora, dopo che lui aveva già ruotato più volte il suo corpo, gli dicevo di fermarsi e di tornare indietro.
Lui si fermava, in silenzio, e tornava al punto di partenza.
Io prendevo un rametto, di nocciolo mi sembrava, e lo posavo subito sotto la lama, sotto quel punto della lama che al solo guardarlo mi sembrava dovesse tagliare.
Non soddisfatto riprendevo in mano il rametto, lo orientavo con la parte più spessa e resistente verso il basso e lo conficcavo nel terreno, come un piccolo palo.
Mio nonno senza aspettare oltre, proprio mentre io incominciavo col ritirare la mano, riprendeva il movimento rotatorio, in senso orario, contrario a quello di taglio.
La punta della falce, quella vera, quella che si insinuava tra gli steli d’erba, per uscirne vincitrice, sfiorò appena il rametto.
Mio nonno rallentò quasi a fermarsi.
- guarda nonno! Nello stesso punto! Passa nello stesso punto senza buttare giù il rametto!
La lama ha l’inclinazione giusta. Il ferro è a posto. – Mi insegnò.
Un barattolo di conegrina. Bianco. Senza etichetta né altro. Solo due segni a bassorilievo.
Uno di tre lettere a indicare una marca che avevo sentito alla televisione assicurarmi che non avrebbe mai strappato i vestiti; le stesse tre lettere che poi avevo rivisto in un supermercato sulla bottiglia di un succo arancione la cui etichetta ricordava l’importanza delle vitamine e pensavo che forse era per quelle vitamine che i vestiti non si strappavano.
Nell’altro segno a forma di esagono ci stavano due sole lettere che, a detta di mio padre, mi indicavano il composto chimico che avevo tra le mani: una serie infinita di doppi legami che continuavano ad essere utili per contenere la cote.
Fantastico strumento da impugnare. Di pietra. Dura, ma fragile. Ruvida, ma regolare.
Quella pietra molitoria sembrava volare tra le mani di mio nonno.
L’arco di Ulisse, la racchetta di Mac Enroe, quella pietra sembrava la continuazione naturale della sua mano.
Sfiorava la lama. Sembrava non toccarla, eppure sentivo il rumore.
- devi stare sempre parallelo alla lama, mai inclinato verso l’interno, sennò mangi il filo e così poi dobbiamo battere il ferro.
Provavo. Guardavo. Prendevo le misure provando il gesto nell’aria. Sentivo l’umido dell’acqua di cui era impregnata la cote scivolarmi tra le dita.
Appoggiavo l’avambraccio sinistro sulla parte alta della lama, quella in cui il ferro era rinforzato e arrotondato come una schiena.
Il pollice e l’indice li serravo attorno a questo cordone di rinforzo verso la fine della lama, vicino al manico.
Ero alto si e no un metro e mezzo, così dovevo inclinare il ferro e lo tenevo fermo tra le gambe.
Mio padre aveva comprato al mercato un modello nuovo di falce, di quelli col manico in ferro al posto di quello in legno che aveva costruito mio nonno; e così per tenerlo fermo dovevo stringerlo tra le cosce, scoperte dai calzoncini corti che usavo per giocare al pallone nel cortile dell’oratorio. Il ferro era freddo.
La mia mano partiva convinta dal cervello per posarsi indecisa sulla lama.
Molavo, ma il ferro non tagliava.
La cote e il suo contenitore stavano appoggiati al passante dei vecchi jeans.
Il contenitore in plastica era infatti sagomato da un doppio giro di fil di ferro che si attorcigliava in un gancio sufficientemente robusto da reggere il peso della cote senza strappare la tela dei pantaloni.
La sua mano, lenta, scivolava lungo il fianco e poi scompariva dietro la schiena per uscirne, dopo un sordo rumore di acqua smossa, armata della cote.
Con un leggero colpo di polso l’acqua, in cui la cote era a bagno, scendeva a terra a grossi goccioloni.
Dopo quella sequenza di gesti mi aspettavo che mio nonno facesse roteare la cote tra le dita come vedevo fare ai cow-boy nei western alla televisione con le loro pistole appena sfoderate dalle fondine.
Invece stendeva l’altro braccio sul dorso della lama e appoggiava il manico della falce sotto un ginocchio.
Puliva il filo della lama dalla terra e dall’erba rimastavi attaccata con le tre dita libere, mentre pollice ed indice continuavano a stringere la cote.
- Vai sempre fino in fondo, ché è tutta la lama che taglia. Tieni sempre la stessa pressione sennò mangi di più una parte e fai gli scalini sulla lama.
Mi istruiva senza sapere dove io realmente fossi. Non mi guardava mai, se non alla fine della frase per assicurarsi, guardandomi dritto negli occhi, che avessi ascoltato e capito. Una radiografia cerebrale.
E poi ricordo quel suono. Squillava. Lo sentivo nelle orecchie, regolare, mai un accento, mai un’asincronia.
Poi, il taglio.
La falce galleggiava sull’erba.
Non un colpo, ma un movimento rotatorio continuo. Un arco di quasi centoventi gradi.
Dal fianco destro fin oltre la spalla sinistra.
Il suo sguardo seguiva la lama e il mio sguardo seguiva il suo e non capivo se era la lama o se erano gli occhi a tagliare l’erba.
Cercavo l’iride grigio di mio nonno e mi aspettavo di vederne uscire un fascio luminoso, come quello con cui alcuni mostri dei cartoni giapponesi radevano al suolo le città.
Seguivo il suo corpo in quel ballo armonico.
Mai prese larghe.
L’erba si coricava in piccoli fasci ordinati e non provavo la pena che invece mi lasciava la lettura di Cipì.
Un taglio per una nuova vita: sia animale che vegetale.
Era il mio turno.
Mio nonno si fermava, asciugava il sudore che gli scendeva sul profilo del naso, una goccia oscillava fino ad irrorare l’erba appena tagliata; volgeva il suo sguardo a cercarmi e mi porgeva la falce che, incastrata sotto la sua ascella sinistra, riposava, mentre sorreggeva il peso del suo corpo.
Il mio movimento era a strattoni, come un vecchio motore ingolfato.
Mai un colpo rotondo. Sempre un angolo troppo stretto o una presa troppo larga.
L’erba cadeva in disordine, e provavo pena.
Gli steli delle graminacee, delle ombrellifere, dei ranuncoli, sembravano trasformarsi tutti in giovani getti di susino o polloni di pioppo: legnosi fin da piccoli.
Il mio colpo era sempre più irregolare, forte, ma indeciso.
- non strozzare, che rovini la lama e ti stanchi le braccia! -
Ampolle di pelle traslucida, ripiene di liquido comparivano alla base delle mie dita.
Al lacerarsi del sottile strato di pelle il liquido scivolava fino a terra, cadendo accanto alle gocce di sudore e vicino ad altro liquido vegetativo lasciato dall’erba appena tagliata.
Sono passati vent’anni: uso sempre la stessa falce.
Mia madre il tosaerba, quando trova qualcuno che glielo mette in moto.